Il numero dell’ “Espresso” in edicola in questi giorni riporta un’inchiesta sulle biblioteche delle università e sul loro precario funzionamento. Anche alcune riviste specializzate nell’analisi della vita universitaria hanno recentemente dedicato la loro attenzione ai servizi bibliotecari rivolti a docenti e studenti degli atenei italiani ed io stesso sono intervenuto sull’argomento alcuni mesi fa in “Lettera matematica”, rivista del Centro PRISTEM della Bocconi.
Personalmente ritengo che un rafforzamento del ruolo delle biblioteche nella vita accademica passi attraverso il riconoscimento della loro funzione formativa. Esse dovrebbero diventare le protagoniste di una vera e propria campagna di information literacy, un terreno su cui accusiamo gravi ritardi e da cui dipende gran parte della qualità di una nuova generazione di studiosi e professionisti. La biblioteca non è soltanto un servizio di supporto all’attività didattica e di ricerca, con una funzione meramente ancillare, ma una delle componenti del processo formativo che in questi istituti si compie. Le capacità di analisi e di interpretazione dell’informazione non si creano spontaneamente tra gli studenti: sono il risultato di percorsi specifici strettamente collegati alle tipologie documentali e alle pratiche di ricerca che caratterizzano ciascuna comunità scientifica.
Per questo motivo è indispensabile che le università e le loro biblioteche si dotino di programmi di educazione e formazione dell’utenza, anche integrando i contenuti dei percorsi curricolari con ore di lezione, riconosciute da crediti formativi, dedicate all’utilizzo della biblioteca fisica o digitale ed agli strumenti avanzati di ricerca e disseminazione dell’informazione.
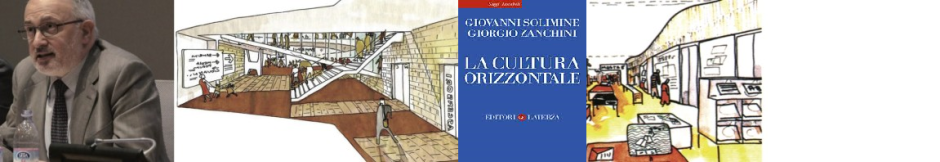
Sarebbe da rispolverare la legge del 1998 che permette il ritorno alle università delle biblioteche universitarie statali, finora applicata solo a Bologna nel 2000.
Così potrebbero occuparsi soltanto di attività bibliotecarie, usufruendo degli uffici amministrativi e tecnici dell’università, diventandone parte integrante anziché organi periferici di un altro ente: per adesso, la gestione autonoma di ogni istituto ha molti più oneri che onori, dovendosi svolgere tutte le pratiche spicciole e poi trasmetterle al centro.
A Bologna il problema maggiore era il reinquadramento del personale dal comparto ministeri al comparto università, ma lo si può evitare passandolo con status immutato fino a esaurimento dal Ministero dei beni e attività culturali e del turismo al Ministero dell’istruzione università e ricerca, localmente rappresentato dal Rettorato.
How do you assess the role of biblioteches in academic life and how do you hope that role is strengthened?
Regard Telkom University
L’articolo di Giovanni Solimine evidenzia un tema cruciale per le biblioteche universitarie: la loro evoluzione verso un ruolo formativo più forte attraverso l’**information literacy**. Il concetto di “alfabetizzazione all’informazione” è fondamentale, poiché le capacità di analisi e interpretazione delle informazioni non si sviluppano automaticamente tra gli studenti, ma devono essere coltivate attraverso percorsi specifici.
Le biblioteche non devono più essere viste come semplici supporti accessori per le attività didattiche e di ricerca, ma come componenti integranti del processo formativo, con il compito di educare gli studenti nell’uso corretto e consapevole delle risorse documentali e tecnologiche a loro disposizione. Solimine sottolinea l’importanza di programmi educativi mirati, che possano essere integrati nei curricula universitari e che riconoscano il valore delle biblioteche sia fisiche che digitali.
Il rafforzamento del ruolo delle biblioteche universitarie è quindi essenziale per la qualità dell’istruzione superiore in Italia e per formare una nuova generazione di ricercatori e professionisti preparati ad affrontare la sfida della gestione e diffusione delle informazioni in un mondo sempre più digitalizzato.
Good Information
Regards, Unissula